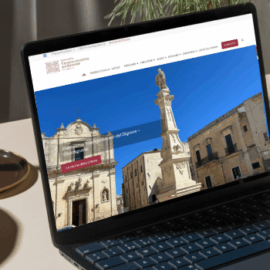Ad un anno dalle elezioni comunali, quando le carte delle liste elettorali sono ancora coperte, le alleanze cercano di consolidarsi e i programmi in fase di studio, in quanto pastore di questa Comunità cristiana sento il dovere, per tempo e con modo, di indicare alcuni orientamenti che possano illuminare un appuntamento appassionante e delicato per l’intera Comunità, quale quello elettorale.
Chiesa e politica
Sono consapevole che la prima accusa che mi sarà rivolta è che “la Chiesa non deve fare politica” e che “deve tenersi fuori dalla politica”. Queste frasi sono pertinenti se si intende esprimere con esse il bisogno di superare un certo tipo di rapporto che l’istituzione ecclesiale ha avuto in passato con il potere politico, quello che si vuole qualificare come “teocratico”. Tuttavia queste frasi lette alla luce del Concilio Vaticano II implicano due errori: anzitutto, quello di identificare la Chiesa con coloro che in essa detengono l’autorità e non come il popolo di Dio, popolo di battezzati; poi, quello di pensare che c’è un solo modo ecclesiale di rapportarsi con la politica, e cioè quello teocratico appena accennato.
È anzitutto la Gaudimu et Spes (GS), la Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, sottoscritta dai Padri Conciliari e da papa Paolo VI il 7 dicembre 1965, a illuminarci sul rapporto tra la Chiesa e la vita politica.
Per evitare che si ripetano le situazioni del passato sopra ricordate, la GS si premura, anzitutto, di scartare ogni forma di visione teocratica della politica, stabilendo la netta distinzione tra la Chiesa, in quanto comunità radunata all’insegna della fede, e la società politica, in quanto radunata all’insegna della convivenza umana. Dichiara infatti: “La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana. La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo”[1].
Lo stesso documento poi sottolinea anche l’aspetto complementare di quanto ha enunciato: “Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo”[2].
Poiché, quindi, tanto la politica quanto le politiche sono delle componenti del mondo che la Chiesa vuole servire nella sua crescita in umanità, esse non possono restare al margine della sua preoccupazione e della sua azione. È l’intera comunità ecclesiale che se ne deve occupare, conscia della responsabilità che le incombe alla luce del Vangelo. Non se ne può “lavare le mani”, mantenendosi totalmente a margine di essa.
Di tale incombenza se ne trova un’affermazione densa e programmatica in questo testo, sempre al capitolo già accennato: “Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità”[3]. Risulta chiaro nel testo chi sia il soggetto di questa “speciale vocazione nella comunità politica”[4]: sono “tutti i cristiani”.
Il servizio alla politica
Il Compendio della Dottrina Sociale Cattolica ricorda che “per i fedeli laici l’impegno politico è un’espressione qualificata ed esigente dell’impegno cristiano al servizio degli altri”[5]. Il servizio per gli altri si manifesta dunque attraverso un qualificato e competente impegno politico, che passa anche attraverso il rispetto, la responsabilità e l’autorevolezza dell’istituzione sociale e politica. D’altro canto, i rischi sono quelli di servirsi della politica ma non di servire gli altri, di un impegno sommario e di macchiare l’istituzione sociale e politica con logiche mondane, ben lontane da qualsiasi qualificazione morale.
Papa Francesco ci ricorda che ciò caratterizza l’impegno politico del cristiano è la carità politica[6] che “presuppone di aver maturato un senso sociale che supera ogni mentalità individualistica: «La carità sociale ci fa amare il bene comune e fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce»[7]
La politica che vogliamo
Il dibattito politico è caratterizzato dalla sua legittima dialettica, del tutto peculiare in tempo di elezioni. Tuttavia l’impegno politico del cristiano impone uno stile finalizzato a custodire nella Comunità civile, della quale ci si mette a servizio. Possiamo individuare alcuni orientamenti che possono costituire la cartina tornasole di un confronto politico:
- L’unità e la coesione sociale: in un tempo di grandi crisi e incertezza nel futuro (situazione pandemica, conflitti, disoccupazione, etc.) in cui la nostra Comunità, come tutte, ne ha fortemente risentito, non è bene che l’appuntamento elettorale diventi l’ennesima causa di frantumazione di una Comunità piccola ma sempre cortese e operosa. Bisogna custodire con gelosia una pace cittadina, di cui ognuno ne ha diritto. Il confronto elettorale sia il più sereno possibile, basato sui programmi ben articolati, e che sfugga a qualsia spettacolarizzazione della politica basata sull’affronto personale. Ai vinti e ai vincitori toccherà l’onore e l’onere di custodire, con una stretta di mano, l’unità e la coesione sociale dell’intera cittadina.
- L’attenzione ai poveri e alle povertà: se l’impegno politico è mettersi laicamente a servizio degli altri, questo servizio non può esimersi dal tenere in considerazione in primo luogo le diverse povertà che caratterizzano il nostro territorio. Sono essi infatti gli unici ad avere il diritto ad alzare la voce in un comizio elettorale. Non si tratta dunque si affrontare solo povertà materiali o economiche, ma quelle più difficili da stanare e anche le più gravose, come la solitudine, la dispersione scolastica, l’alcolismo, la ludopatia, la disoccupazione, l’isolamento sociale, etc. In senso più largo, come ci ricorda Papa Francesco: “la politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia”[8] ma è necessario che “i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società”[9];
- La ricerca del bene comune: in una società fortemente individualista, la ricerca e la realizzazione del bene comune viene fatta…in comune, cioè insieme. “L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali. Ma l’individualismo radicale è il virus più difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune”[10] ma invece il bene comune “essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. Come l’agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l’agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune. Il bene comune, infatti, può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene morale”[11]; Sia la ricerca dell’autentico bene morale per la Comunità a far ricercare e realizzare il condiviso bene comune.
- Passione per la politica: l’appuntamento elettorale può diventare l’occasione di avvicinare le giovani generazioni, e non solo, all’impegno politico. Se da un lato non sono i discorsi sui massimi sistemi ad accendere il fuoco della passione politica e l’interesse per il proprio paese e territorio, è anche vero non saranno neanche che le bagarre politiche, i giochini di bassa politica senza etica né valori ad accendere l’amore per ciò “che attiene alla città”.
Per concludere
Per il cristiano non si tratta dunque di esentarsi dal dibattito politico- elettorale, ma anzi, di entrarci pienamente con lo stile tipico del cristiano. Si tratta di pretendere e dare il meglio dall’appuntamento più importante della vita democratica per una Comunità civile e religiosa come attenzione alla realtà presente e come investimento a lungo termine per quella futura.
La speranza è che queste mie parole non vengano in alcun modo né fraintese né strumentalizzate e possano esortare ad un confronto politico proficuo e costruttivo ma soprattutto pacifico e riconciliante per una Comunità già segnata dalla pandemia e dalle diverse preoccupazioni economico-sociali legate ai nostri giorni così da far riaccendere la passione per la politica e poter dire, come La Pira: “Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa “brutta”! No: l’impegno politico, è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità”[12].
[1] CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et spes (7 dicembre 1965), n. 76.
[2] Ivi.
[3] Ibidem, 75.
[4] Ivi.
[5] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale cattolica, n.565.
[6] FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020), n. 180.
[7] Ibidem, n. 182.
[8] Ibidem, n. 177.
[9] Ibidem, n. 187.
[10] Ibidem, n. 105.
[11] PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale cattolica, n.164.
[12] G. LA PIRA, La nostra vocazione sociale, Roma, AVE ed., 20043, p.80.